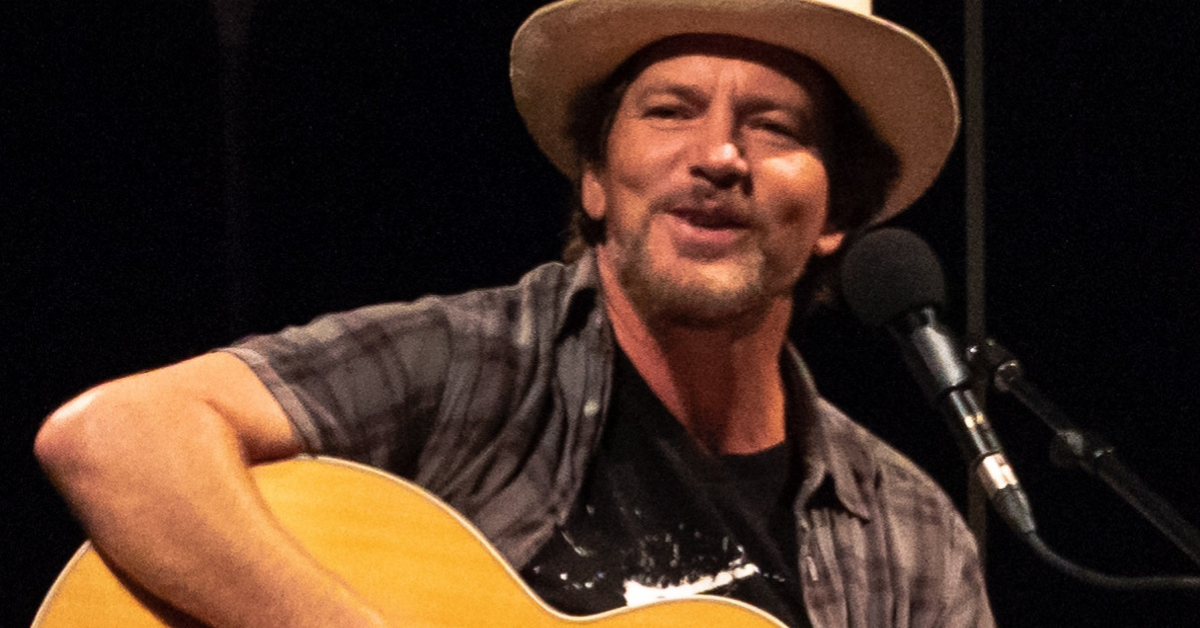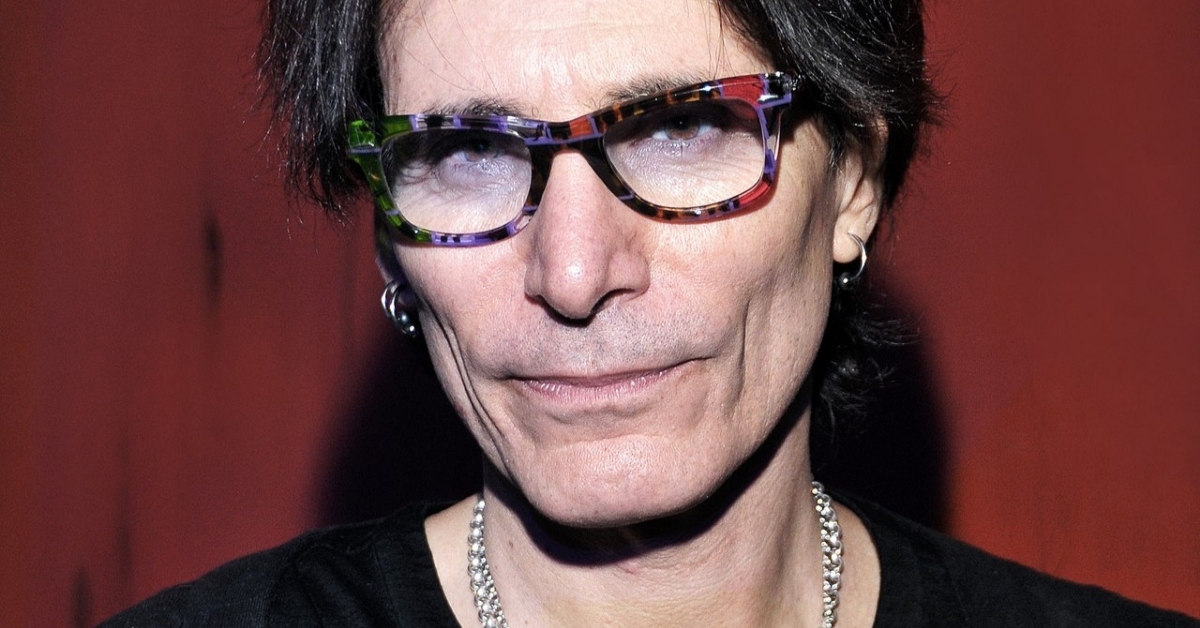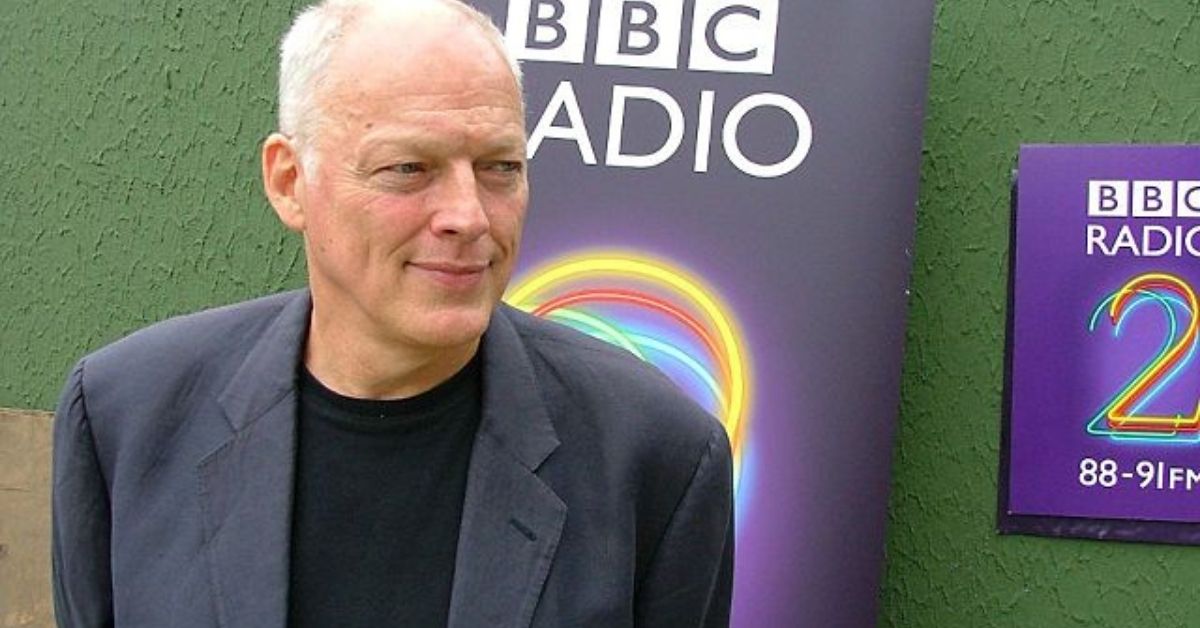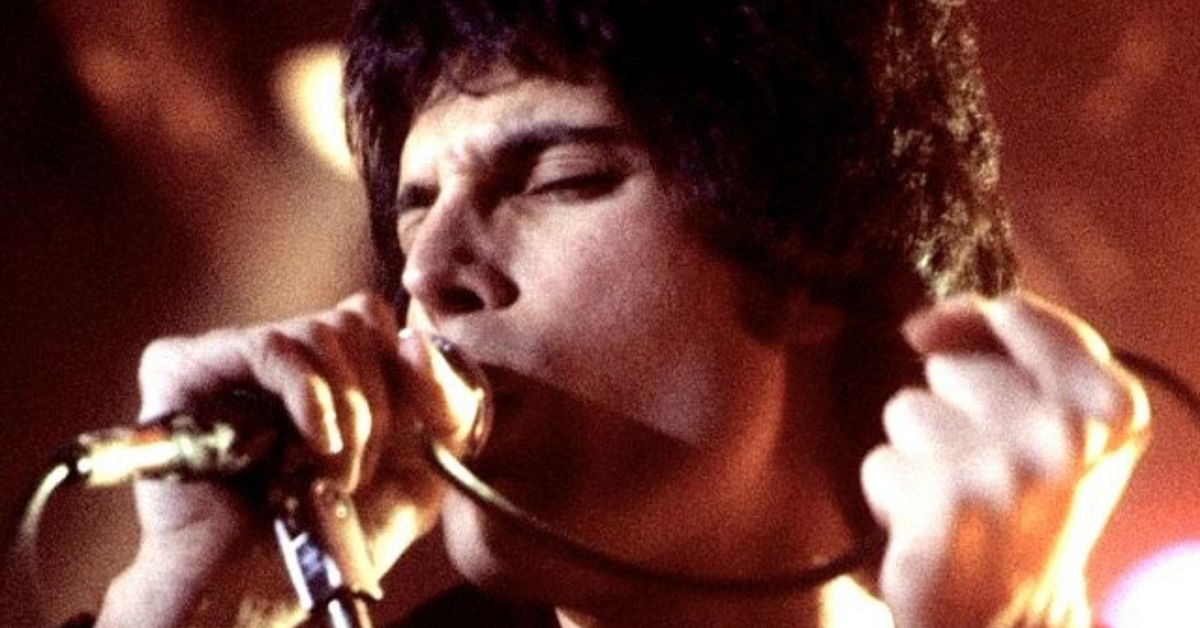Superare il limite dell’impareggiabile e giungere in un ambito del tutto differente è possibile; lo è stato, ne abbiamo una prova: i Muse hanno dominato lo Stadio Olimpico di Roma attraverso un concetto – e una concezione – di concerto che inedita non è, ma che risulta essere potenziata, quasi utopica: si potrebbe tranquillamente affermare di aver vissuto, per qualche ora, in un futuro lontano 20 o 30 anni, senza farsi troppi problemi, senza cadere in un’ipocrisia dettata dall’apprezzamento o dai gusti personali. I Muse hanno offerto al pubblico romano uno spettacolo incredibile, un’esaltazione superomistica di quel che è l’arte, un qualcosa di irripetibile che sa coniugare musica, scenografia, impatto, coinvolgimento e passione. Ma procediamo per tappe, cercando di evidenziare ciò che abbiamo colto nelle diverse ore di una giornata memorabile.
Tra Leopardi e Lessing: se un concerto può diventare un concetto filosofico
Non prendiamoci in giro: non è stato il primo e non sarà l’ultimo concerto vissuto con questo spirito, con quel concetto di bellezza e di passione che sta in ore e ore di fila. Gotthold Ephraim Lessing affermava, in quella celebre sentenza che è poi diventata marchio di pubblicità e filosofie spicciole, che l’attesa del piacere è essa stessa il piacere; Leopardi, spostando il tutto su un piano differente – lo stesso che ha permesso a grammatici e storici di recargli quella denominazione di “pessimista” -, evidenziava il carattere illusorio dello stesso, affermando che un piacere presente non esiste.
Ma andiamo al sodo: dalle 8 alle 16.30 ci sono oltre otto ore di fila, a cui si aggiungono altre quattro ore di attesa prima dell’inizio del concerto. 12 ore totali di tutto: dalla noia alla stanchezza, dalle conversazioni alle amicizie improvvisate, dalla bottiglia d’acqua senza tappo da far entrare fino agli avvertimenti della sicurezza. Rinunciare a tutto ciò? Neanche per sogno: è l’evento prima dell’evento, lo spettacolo prima dello spettacolo, la filosofia su cui si fonda tutto il bello a cui si assiste; il concerto diviene la ricompensa, se vogliamo pensarla in questo modo, di un’interminabile attesa che non sfianca nessuno, ma che crea soltanto aspettative, illusioni e – gradualmente – sempre più gioia.
E allora tutto è più bello, ogni particolare è migliore (non importa quale sia la vista e quale la posizione), ogni nota è un regalo, ogni canzone è manna. Vale per ogni concerto, è valso per il concerto dei Muse a Roma: è il segreto che porta ad amare ulteriormente tutto ciò che si osserva. Ogni spettatore, dopo una tempra simile, non è il bersaglio di un assolo di chitarra o di una canzone ascoltata passivamente, è parte viva e integrante del tutto.
Il neonato e il futurista: il racconto del concerto dei Muse a Roma
Dopo la pubblicazione di Simulation Theory gran parte della critica e dei fan della band si è mossa verso un orizzonte piuttosto chiaro: i Muse non sono rock o, almeno, non lo sono più. Forse è vero, se si considera il prodotto stesso che la band offre e ha offerto attraverso il suo ultimo album in studio: il fatto che sia vero o verosimile, però, non implica che ciò sia un limite o un difetto. La dimensione che la band è riuscita, dopo anni di esperienza, a raggiungere con le ultime prestazioni non ha un genere, un’etichetta, un’appartenenza: è totale, magnifica, utopica e universale.
Ciò porta ad un pregio che difficilmente si può vantare nella storia della musica, soprattutto contemporanea: non importa avere la stessa idea di musica, la passione sfrenata per la band o l’amore per tutte le canzoni dei Muse; si può godere a grandi livelli dello spettacolo della formazione britannica comunque, e in ogni caso.
Ed ecco il segreto del grande successo dei Muse a Roma: la formazione britannica ha saputo abbattere ogni barriera, attirando fan da ogni dove e con diverse, e talvolta antitetiche, concezioni musicali e artistiche; ha saputo vincere il limite dall’etichetta, attraverso una commistione che ha saputo accogliere brani futuristi come Propaganda e Pressure, storici e datati come Starlight e Uprising, immortali come New Born e Plug in Baby; una commistione a cui si sono aggiunti la splendida chiusura di Knights of Cydonia e il medley perfetto con Stockholm syndrome, Assassin, Reapers e The handler.
E non è finita qui: dicevamo, inizialmente, di poter parlare tranquillamente di uno spettacolo in grado di proiettare 20 o 30 anni in avanti. Uno spettacolo futurista, utopico, che spiana la strada alle moderne concezioni di concerto globale; uno spettacolo, a dirla tutta, che non ha fatto a meno di nulla: dai laser agli occhiali led, dalle ballerine agli astronauti, passando per Murph, il robot alieno che ha dominato il palco al termine del concerto. E non importa avere necessariamente Matthew Bellamy davanti ai propri occhi per tutta la durata dell’esibizione, se si può godere di tutto il resto.

Murph, il robot alieno dei Muse nel concerto allo Stadio Olimpico di Roma / © Paolo Bracciano
Il concerto è finito, naturalmente, con Knights of Cydonia, con quella che può definirsi, cioè, un’opera di comunità: dopo due ore intere di concerto si è consapevoli che ci si trova di fronte all’ultima canzone, e allora non si pensa più a nulla, si salta e si balla, si urlano le ultime parole e si condivide quella gioia con chiunque sia accanto, dietro o avanti. Ed è così che i Muse hanno salutato Roma: nella gioia comune, in quel sentimento di appartenenza che non ha avuto bisogno di un genere, di una canzone specifica o di un’ideologia particolare. Alla fine, solo alla fine, si può cedere alla stanchezza: ma a quel punto non è più un problema.